Il “testamento del capitano”, canto piemontese di oltre cinque secoli
di Michele D'Ambrosio
Basta solo sussurrare le parole “Il testamento del capitano” o, ancora meglio, iniziare a canticchiare “Il capitan della compagnia…” in una qualsiasi piazza o, semplicemente, tra poche persone, anche sconosciute, che a tutti viene in mente una sola immagine: la Penna nera; ma da dove proviene questo canto così mesto, e per certi aspetti macabro, che tante emozioni suscita in chi lo ascolta?
E’
uno dei canti più celebri e commemorativi del Corpo degli Alpini, ma
non nasce come canto alpino; le origini di questo testo vanno
ricondotte, con ogni probabilità, a un canto cinquecentesco che ha
come protagonista il Marchese di Saluzzo. La versione conosciuta
oggi, infatti, risale alla Grande Guerra e alle nefaste vicende che
la caratterizzarono.

Siamo nel XVI secolo, la morte del Marchese Michele Antonio di Saluzzo, avvenuta ad Aversa nel 1528 durante le sanguinose guerre di Carlo V in Italia, ha gettato le basi per una versione embrionale della canzone che oggi conosciamo. Il titolo con cui si raffigurava all’epoca era “La Ballata del Marchese di Saluzzo”. Inizialmente tramandata oralmente, troviamo le prime tracce scritte del testo originale nei versi raccolti dal filologo piemontese Costantino Nigra nel XIX secolo. Il Marchese di Saluzzo, prossimo alla morte sul campo di battaglia, chiede ai suoi figli d’arme che il suo corpo esanime sia ripartito in quattro parti e nel seguente ordine: la testa vuole che sia consegnata alla madre in lacrime, il cuore alla promessa sposa, Margherita, che, ancora ignara di quanto sta per accadere, spera di poterlo riabbracciare al più presto, le due parti restanti, invece, ordina che vadano consegnate rispettivamente alla Francia e al Monferrato. Di seguito una delle quattro versioni attestate dal Nigra, raccolta a Leinì dalla voce di una contadina.
Sur capitani di Salüsse
l’à tanta mal ch’a mürirà.
Manda ciamè sur capitani,
manda ciamè li so soldà;
quand ch’a l’avran muntà la guardia
o ch’a l’andéisso ün po’ a vedè.
I so soldà j’àn fait risposta
ch’a l’àn l’arvista da passè.
Quand ch’a l’avran passà l’arvista
sur capitani andrio vedè.
“Coza comand-lo, capitani,
coza comand-lo ai so soldà?”
“V’aricomand la vita mia
che di quat part na débie fa.
L’è d’üna part mandè-la an Fransa
e d’üna part sül Munferà.
Mandè la testa a la mia mama
ch’a s’aricorda d’so prim fiöl.
Mandè ‘l corin a Margarita
ch’a s’aricorda dël so amur.”
La Margarita in sü la porta
l’è cascà ‘n terra de dolur.
Signor capitano di Saluzzo
ha tanto male che morirà.
Manda a chiamare, il signor capitano
manda a chiamare i suoi soldati;
quando avranno montato la guardia
che andassero un po’ a vederlo.
I suoi soldati gli hanno risposto
che devono passare la rivista.
Quando avranno passato la rivista
andranno a vedere il signor capitano.
“Che cosa comanda, capitano,
che cosa comanda ai suoi soldati?
Vi raccomando il corpo mio
che quattro parti ne dovete fare.
Una parte mandatela in Francia
e una parte nel Monferrato.
Mandate la testa alla mia mamma
che si ricordi del suo primo figliolo.
Mandate il cuore a Margherita
che si ricordi del suo amore”.
La Margherita, sulla porta,
cadde a terra per il dolore.
|
|
Da questa base, sin da subito, nacquero numerose versioni in Emilia – Romagna, in Trentino, nel Veneto e nello stesso Monferrato, declinate nelle varie vicende locali.
Il canto alpino, così come lo conosciamo oggi, nacque con ogni probabilità sull’Adamello durante il primo conflitto mondiale e si diffuse presto lungo tutto il fronte di guerra. Per il contesto storico in cui è tornato in “in uso” è considerato un canto nazionale e non regionale. Anche di questa versione più moderna, siamo a conoscenza di un numero notevole di versioni , di solito costituite da cinque, sei o sette strofe. Il testo, nella maggior parte delle versioni, è fornito di sgrammaticature e influenze dialettali, ma rappresenta la figura del Capitano come una figura paterna e degna di onore, dignità e dedizione anche in punto di morte. È di insolito e notevole rilievo l’incipit del brano: il tono non è militare e tipico degli ordini impartiti dai superiori, ma di fratellanza e familiarità (seppur sentimenti lontani su un qualsiasi fronte di guerra); il Capitano, infatti, invoca i suoi soldati, definiti da lui stesso “i suoi Alpini”, perché ha piena fiducia in loro ed è certo che, al suo richiamo, accorreranno come figli al capezzale del padre morente. Il tono narrativo prosegue con un climax ascendente straordinario quando il Capitano, in punto di morte, fa testamento delle parti del suo corpo; nella suddivisione del suo cadavere, il morente segue una logica ben precisa: inizialmente istituzionale e patriottica, poi dal sapore più affettivo e trascendentale, come una sorta di passaggio dalla vita terrena, che lo ha visto militare, all’immensità della vita eterna, collocata da lui nella quiete delle montagne. Il canto, infatti, si conclude con il verso “l’ultimo pezzo alle montagne che lo fioriscano di rose e fior”; a primo impatto, questo finale, potrebbe sembrare una sorta di glorificazione dei valori militari espressi in precedenza, ma non è così: le montagne, quelle a cui il Capitano è tanto legato in quanto Alpino e tra cui sta esalando l’ultimo respiro, sono per lui l’elemento più importante, sinonimo di pace e serenità, quasi un contrappasso, considerando l’inferno che le vede protagoniste.
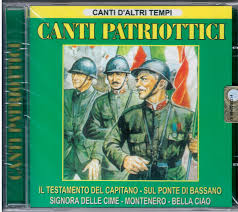
Innumerevoli sono le versioni presenti del brano, ma sicuramente possiamo citarne alcune: durante la Seconda Guerra Mondiale, in onore di un gruppo di Alpini del VII Reggimento e del loro Comandante, il Colonnello Rodolfo Pesaro venne elaborata la versione dal titolo “Il Colonnello fa l’adunata”. Altre versioni, invece, mantennero il titolo, ma cambiarono sostanzialmente nei contenuti, un esempio lampante sono le versioni che circolavano nella Repubblica Sociale Italiana.
Di seguito la versione più conosciuta a 6 strofe:
Il capitan de la compagnia
e l’è ferito sta per morir
e manda a dire ai suoi Alpini
perché lo vengano a ritrovar!
I suoi alpini ghe manda a dire
che non han scarpe per camminar.
“O con le scarpe, o senza scarpe
i miei Alpini li voglio qua”
E co fu stato alla mattina
I suoi alpini sono arrivà:
“Cosa comanda sìòr Capitano
che noi adesso semo arrivà?”
“E io comando che il mio corpo
in cinque pezzi sia taglià:
Il primo pezzo Re d’Italia
Che si ricordi del suo soldà,
secondo pezzo al Battaglione
che si ricordi del suo Capitan,
il terzo pezzo alla mia mamma
che si ricordi del suo figliol.
Il quarto pezzo alla mia bella
che si ricordi del suo primo amor.
Il quinto pezzo alle montagne
che lo fioriscano di rose e fior.”
FONTI:
- Canti della Grande Guerra, V. Savona e M. Straniero, Garzanti 1981
- Canti della montagna, Touring Club Italiano, s.i.d.
