Siamo a settembre e, anche quest’anno, tra mille difficoltà, la campanella delle 8.00 del mattino inizierà a trillare acclamando folle di studenti che si riverseranno nelle proprie aule per poi sedersi ai milioni di banchi sparsi per l’intera Penisola; con qualche differenza, ma questo è un rituale che, da oltre un secolo, caratterizza la nostra scuola ed il nostro sistema educativo. Seppur con le stesse modalità, questo sarà un inizio d’anno del tutto inedito a causa dell’epidemia da Coronavirus che sta martoriando l’intero pianeta. Non sarà facile, dopo le migliaia di morti che ha visto il nostro Paese, ricominciare l’anno, dopo sei mesi circa, come se nulla fosse; è inutile dire che servirà uno sforzo non indifferente da parte di tutti per rispettare e far rispettare tutte le procedure di sicurezza e prevenzione che devono essere adottate per impedire il diffondersi del virus. A poco o a nulla servirà imporre l’utilizzo di igienizzanti e mascherine se poi non verranno rispettate le regole e le disposizioni ministeriali, unite al buon senso di ciascuno. Tornando al tema principale di questo scritto e facendo un salto indietro di qualche anno, possiamo sostenere che le riforme scolastiche che precedettero e seguirono l’unificazione del Paese dovettero tenere conto del divario tra Nord e Sud del Paese sul piano economico, sociale e politico. In tutte le proposte di legge di quegli anni si nota la volontà di costruire, attraverso l’istruzione, un’identità nazionale forte e consapevole. A dieci anni dall’Unificazione, nel 1871, il livello medio di analfabetismo nel Paese era del 70 per cento circa con punte fino all’80 per cento nel Mezzogiorno ed una punta minima del 42 per cento in Piemonte. Significative anche le cifre degli studenti iscritti alle scuole dai 6 ai 12 anni negli Stati preunitari: dal 93 per cento del Piemonte al 43 per cento di media della Penisola. Malgrado questi dati, fin dalla prima metà dell’Ottocento, anche il Mezzogiorno aveva preso coscienza di questa situazione inaccettabile e molte amministrazioni locali avevano compiuto un vero e proprio salto di mentalità portando il problema scolastico al centro delle decisioni. Le amministrazioni iniziarono a vedere l’istruzione obbligatoria e gratuita come un fattore indispensabile di sviluppo e non più come un vero e proprio peso. Per quanto riguarda il Piemonte, invece, dopo un regolamento elaborato nel 1853 dal Ministro della Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna, Luigi Cibario, fu Giovanni Lanza, suo successore, a presentare nel 1855 al Parlamento un progetto di legge per riformare l’istruzione elementare. Il progetto fu esaminato da una Commissione parlamentare dalla quale provenne un controprogetto che vide come relatore Luigi Amedeo Melegari. La commissione contestò a Lanza, ritenendolo inaccettabile, il totale controllo governativo sulla nomina dei maestri contenuto nella sua proposta. Fu solo il 13 Novembre 1859 che, con la legge Casati, si riuscirono a gettare delle vere e proprie basi solide per una prima organizzazione del sistema scolastico nazionale. Tornando alla volontà di voler costruire l’identità nazionale attraverso l’istruzione, anche in campo letterario videro la luce romanzi e scritti rivolti alle nuove generazioni di studenti con l’obbiettivo intrinseco di voler tramandare valori e sentimenti di appartenenza alla neonata Italia; a tal proposito non possiamo non citare 2 romanzi che, bene o male, tutti abbiamo quantomeno sentito nominare: il primo, in ordine cronologico, è uno tra i romanzi per bambini più conosciuti: “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”; il secondo, invece, è l’intramontabile “Cuore” di Edmondo De Amicis, meglio conosciuto come “Libro Cuore”, oggi, purtroppo, caduto in disuso anche tra i banchi di scuola. “Le Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, meglio conosciuto con il titolo di “Pinocchio”, narra la storia di un burattino, nato dalle abili mani di mastro Geppetto, falegname toscano che, per ovviare alla solitudine, scolpisce un burattino da un ceppo di legno. Questo burattino improvvisamente prende vita. Burattino irrequieto, non passa giorno che non si cacci in qualche pasticcio; al posto di andare a scuola, predilige il divertimento e le cattive compagnie dove incontrerà i vari personaggi che caratterizzeranno le varie avventure e disavventure che faranno dannare il povero mastro Geppetto. Il romanzo in questione viene pubblicato per la prima volta a puntate nel 1881 sul periodico “Il giornale dei bambini” diretto da Ferdinando Martini. Collodi, ritenendo il suo scritto un lavoro non degno di grande lode (una bambinata, secondo le sue parole), vide venire meno il suo interesse per questo lavoro e concluse frettolosamente l’opera con le seguenti parole «stirò le gambe e, dato un gran scrollone, rimase lì come intirizzito.»; l’episodio è quello in cui Pinocchio viene impiccato. La critica e i lettori non apprezzarono questa conclusione e la contestarono duramente, questo portò Collodi a proseguire il suo romanzo arrivando alla pubblicazione in volume unico dell’intera opera nel 1883. In questa seconda parte del romanzo troviamo la vera e propria impronta psicologica e padagogica, voluta da Collodi. Il romanzo, infatti, narra di questo burattino che ha come unico sogno quello di diventare, un giorno, un bambino in carne ed ossa. Per raggiungere lo scopo, Pinocchio dovrà “fare giudizio” e comportarsi da bravo bambino iniziando ad andare a scuola e a rispettare tutte le regole; questo lo porterà, a fine romanzo, a diventare «un ragazzino perbene», per usare le parole dell’autore. “Cuore”, al contrario di quanto narrato in Pinocchio, racconta la storia di una terza elementare nella Torino del 1881 – 1882. Protagonista delle vicende è il piccolo Enrico Bottini, figlio di una famiglia agiata e benestante dell’epoca. Il romanzo si sviluppa su tre binari paralleli: il binario del diario, in cui Enrico Bottini narra tutte le vicende, scolastiche e non, in prima persona per tutto l’anno scolastico; il binario epistolare, incarnato dalle lettere del padre e della famiglia al figlio che regolarmente gli vengono scritte; infine, il binario narrativo in cui si collocano tutti i “racconti mensili” che vedono come protagonisti sempre dei bambini, coetanei di Enrico. Questi tre pilasti vengono ad unificarsi tutti quanti in un unico grande scopo, quello educativo e pedagogico dell’epoca. Gli eventi narrati in Cuore sono ambientati nella Torino post-unitaria e vanno dal 17 Ottobre 1881 al 10 Luglio 1882. In questa opera, forse più che in quella trattata sopra, è più che mai evidente l’intento dell’autore di far affezionare i suoi lettori ai temi e ai valori civili del Regno quali rispetto per l’autorità, rispetto per la legge, rispetto per i genitori, spirito di sacrificio per la Patria, eroismo e tutti quei valori che hanno contribuito alla formazione di intere generazioni. L’intera opera è tenuta insieme dalla narrazione sotto forma di diario interrotta, di tanto in tanto, dai racconti mensili e dalle lettere del padre e della famiglia, sempre dedite alla formazione civile ed educativa del piccolo Enrico. Di seguito propongo la lettura di un racconto mensile e di una lettera. Cuore venne pubblicato nel 1886 e, per generazioni e generazioni di studenti, fu una guida ed una tappa obbligata durante il ciclo di studi. Da diversi anni a questa parte, però, questo capolavoro viene sempre più dimenticato ed ignorato, tant’è che nelle scuole non se ne sente quasi nemmeno più parlare, come se fosse una semplice pagina di libro ormai impolverata e in disuso, ma siamo sicuri che questa opera, con i suoi temi ed i suoi valori, sia davvero un qualcosa da far cadere in disuso? Non so quale sia la risposta idonea a questa domanda, sicuramente, però, posso esprimere un parere, del tutto personale, a riguardo. Prendiamo in considerazione due generazioni molto vicine alla nostra: l’attuale generazione di studenti e quella dei nostri genitori, ora paragoniamone alcune peculiarità come il rispetto per i professori, il rispetto per le persone più adulte o, peggio ancora, per le persone più anziane, il rispetto e la memoria per i valori civili e morali, lo stesso sentimento di legame, nel bene o nel male, alla nostra Nazione, ecco, questi sono solo alcuni dei fattori che differenziano, ahimè in negativo, la generazione attuale da quella precedente. Con questo mio pensiero non voglio certo dire che la causa di questo totale decadimento, sociale e morale, sia la non lettura del libro in questione, ma se davvero un albero va giudicato dai frutti, forse quella scuola, ritenuta oggi obsoleta, nozionistica e quanto di più negativo si voglia aggiungere, non era poi così male. La scuola potrà essere considerata la seconda famiglia di ciascuno studente soltanto quando la famiglia diventerà la prima scuola dei rispettivi studenti.
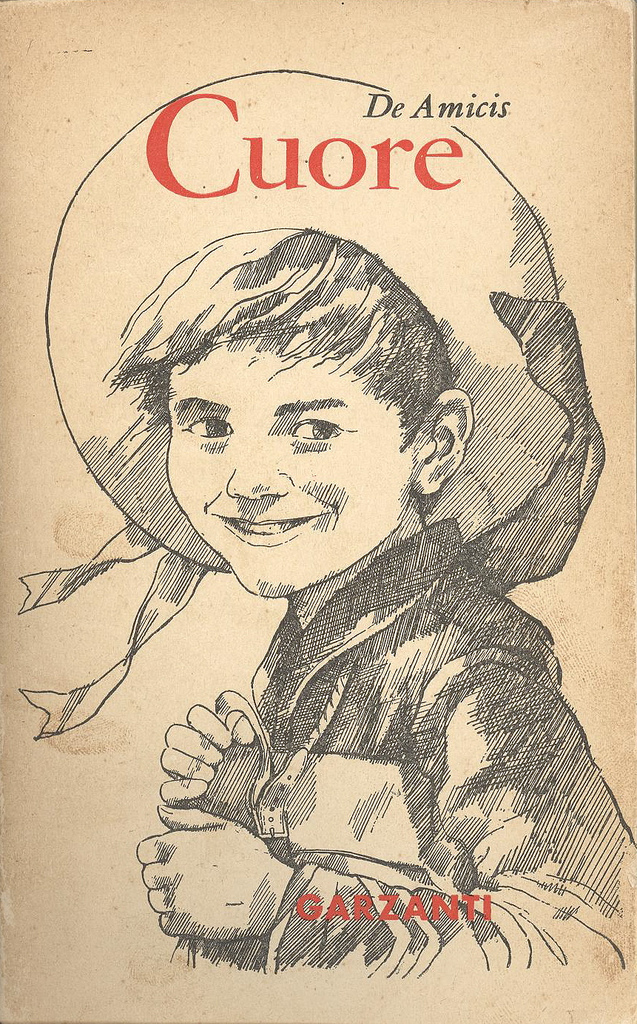
Presidente Michele D'Ambrosio; Segretario Nazionale Pietro Fontana
Web Design Gennaro Capasso
© Italiani Monarchici - Patto per la Corona, 2019
%20-%20copia%20-%20copia.png)
A scuola con Cuore
A scuola con Cuore
28/10/2020 10:04
28/10/2020 10:04
Patto per la Corona
Patto per la Corona //www.italianimonarchici.it/favicon.png
Oggi, micheledambrosio,
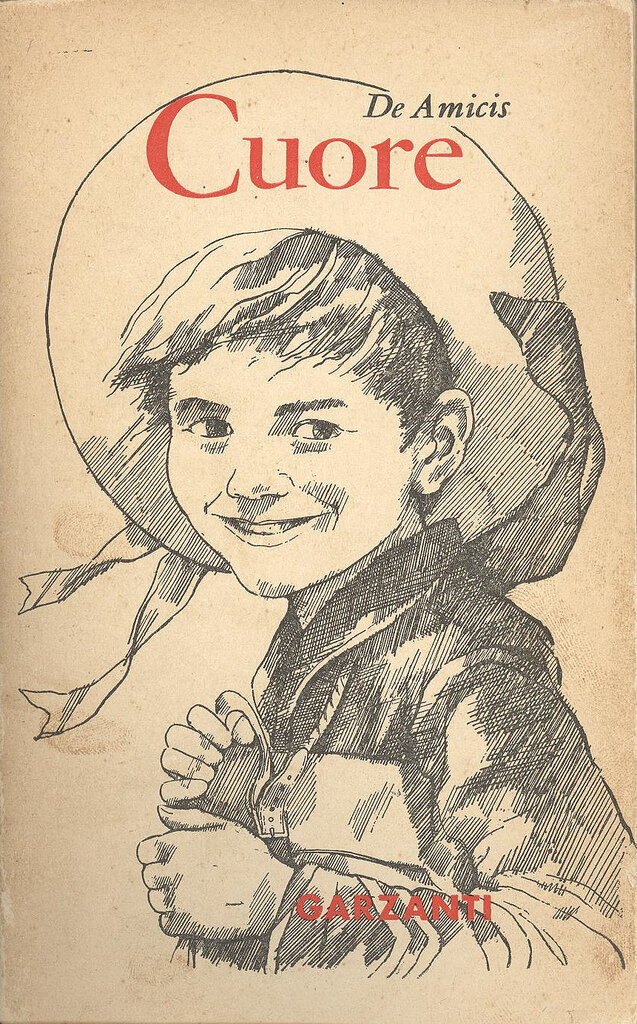
di Michele D'Ambrosio
- Incontro esclusivo con S.A.R. il Principe Aimone di Savoia alla Luiss
- Comunicato stampa della Casa Reale di Savoia - 26/09/2025
- Comunicato ufficiale dalla Consulta dei Senatori del Regno - 29 agosto 2025
- Cixi, una reggente autoritaria
- MEMORIA DI GIOVANNI GIOLITTI LO STATISTA DELLA NUOVA ITALIA
- Trasposizioni inattendibili: il caso di Vittorio Emanuele III in M – Il figlio del secolo
- Kang Youwei
- Partecipazione alla messa di inizio pontificato di Leone XIV
- Partecipazione alle solenni esequie in Vaticano
- Messaggio del Principe Aimone di Savoia nella triste circostanza della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco
- Messaggio di S.A.R. il Principe Aimone | Pasqua 2025
- Intervista rilasciata al “Corriere della Sera” da S.A.R. il Principe Aimone di Savoia, Capo della Real Casa di Savoia (24 marzo 2025)
- La Commemorazione pronunciata dal Senatore Gianni Ruzzier nel Giorno del Ricordo (Rimini, 10 gennaio 2025)
- Giovanni Verga e “I Malavoglia” nel suo tempo, si può parlare di ecologismo letterario? (Parte quarta)
- Messaggio di S.A.R. il Principe Aimone | Natale 2024
- Giovanni Verga e “I Malavoglia” nel suo tempo, si può parlare di ecologismo letterario? (Parte terza)
- Casa Savoia e lo scoutismo
- I Rifugi Sabaudi in Italia
- Giovanni Verga e “I Malavoglia” nel suo tempo, si può parlare di ecologismo letterario? (Parte seconda))
- Giovanni Verga e “I Malavoglia” nel suo tempo, si può parlare di ecologismo letterario? (Parte prima)
- Scomparsa del Principe Michele di Grecia
- Addio al Principe Michele di Grecia
- Terzo anniversario della morte di S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia Duca di Savoia già Duca d'Aosta
- I resti di Ferdinando I arrivano in Bulgaria
- Il Breve Regno di Amedeo I di Spagna: Una Monarchia Effimera
- In memoria di S.A.R. la Principessa Maria Cristina di Savoia Aosta di Borbone delle Due Sicilie
- Messaggio di S.A.R. il Principe Aimone | Pasqua 2024
- FRANCIA E RIVOLUZIONE
- I riti nei funerali reali
- Giacomo Puccini e Casa Savoia: un legame profondo
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (Conclusioni)
- La Danimarca ha un Nuovo Re: SUA MAESTÀ FREDERIK X RE DI DANIMARCA
- Comunicato "Patto per la Corona" sulla morte di Vittorio Emanuele di Savoia
- L’ OSPEDALE DI MAJANO
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (parte seconda c)
- La Resistenza dei Monarchici contro il Regime Fascista
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (parte seconda b), IL DELITTO MATTEOTTI
- In memoria di Norma Cossetto
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (parte seconda a) Comparazione della stampa durante il Governo fascista in concomitanza dell’omicidio Matteotti (19
- I francobolli del Regno d’Italia con Vittorio Emanuele II
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (parte prima) Comparazione della stampa durante il Governo fascista in concomitanza dell’omicidio Matteotti (1925) e
- Vitale Cao di San Marco e i gioielli dei Savoia
- Torta Tenerina
- I Savoiardi
- Monterotondo e il 9 settembre 1943
- L'abito tra noi e gli altri
- Torta Savoia
- La monarchia, l'Italia e gli italiani
- DUE RAMI DELLO STESSO ALBERO
- Il Fondo Cencetti e la Dalmazia
- La Pizza Margherita
- La "Pietra del Destino" all'Incoronazione di Re Carlo III
- Nascita della Regia Aeronautica Italiana e i suoi 100 anni
- Centenario dell’Aeronautica Militare
- I 100 anni dell’Aeronautica militare e l’“Air Force Experience”
- La successione dinastica in Casa Savoia
- Ode al 18 marzo
- A Re Umberto II
- IL RUOLO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA NELLA GRANDE GUERRA – PARTE 2
- Nascita del francobollo
- Qualche riflessione sui mutamenti architettonici nel Sud Italia
- IL RUOLO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA NELLA GRANDE GUERRA
- Il Duomo di Gemona del Friuli
- L’Indipendenza degli Stati Uniti d’America dal colonialismo inglese
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 6
- La vita torinese del Principe di Piemonte
- Conferenza del 29 ottobre 2022
- Fondazione Villa Piccolo di Calanovella
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 5
- Conoscere l’Anpi
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 4
- Dante e il Monarchia
- Nascita e formazione del Principe Umberto
- August von Mackensen: l’uomo delle “cinque Germanie”
- Le visite ufficiali (e non) di Umberto II a Varese
- A tavola con gli antichi romani
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 3
- Messaggio di SAR il Principe Aimone al Liceo Amedeo di Savoia di Pistoia
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 2
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia
- Un ricordo di un grande: Totò
- La kalokagathia
- Il corvo
- LA FAMIGLIA REALE DI SAVOIA – Parte prima (Vittorio Emanuele II ed Umberto I)
- L' Arco di Costantino
- AMEDEO DI SAVOIA OTTANTA ANNI DOPO (1942-2022)
- Il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II (1952-2022)
- Palazzo Aeronautica 1931-2021
- Progetto a medio-lungo termine: eliminazione dell'uso dei contanti
- Rudolf Hess presso la corte del duca di Hamilton
- Il 50° discorso alla Nazione della Regina Margrethe II di Danimarca nel segno della continuità
- Saracinesco - Un Paese di discendenza araba nella Valle dell’Aniene
- La linea dei Savoia Duchi di Genova (1831-1996)
- Puccini ricordato nel giorno della sua nascita
- LUDWIG VAN BEETHOVEN: IL TITANO DELLA MUSICA (1770-1827)
- Recensione del libro “Cifra reale”
- Italiani Monarchici – Patto per la Corona: un bilancio 2021 nel segno della crescita.
- Simeone II di Bulgaria: da Zar a Primo ministro
- Storia e ruolo del Cattolicesimo nella caduta del Regime comunista in Ungheria, parte 2 Caduta del Regno e terrore
- Il centenario del Milite Ignoto
- In principio era solo D’Annunzio. Contro uno e contro tutti. L’alba prima del tramonto
- Scomparso il partigiano Claudio Perra, Carabiniere reale che assistette all'arresto di Mussolini
- Il profondo legame tra Milite Ignoto e Corona
- Cibo da Re
- Gioacchino Volpe (1876-1971)
- Appello associativo sul Centenario del Milite Ignoto
- Relazione sulla serie di eventi del 16 e 17 ottobre 2021 a Roma in celebrazione del genetliaco di SAR il Principe Aimone, Duca di Savoia, e in memoria dell’Augu
- Messaggio di SAR il Principe Aimone, 16 ottobre 2021
- Storia e ruolo del Cattolicesimo nella caduta del Regime comunista in Ungheria
- Dante Alighieri: 700 anni dopo
- Ciciliano e il castello Theodoli - un borgo cresciuto intorno alla fortezza
- La Reggia di Colorno ...e i Savoia
- Intervista a SAR la Principessa Soraya Malek per un Afghanistan finalmente libero
- Papa Francesco e la stretta sul rito antico. La questione liturgica alimenta il dibattito nella comunità cattolica.
- La grande musica riapre il sipario sull’Italia - L’Aida diretta da Riccardo Muti all’Arena di Verona
- Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957)
- Francesco V d’Austria-Este
- L'Arma dei Bersaglieri festeggia il suo 185mo anniversario
- 1861-2021 IL CENTOSESSANTESIMO DELLA MORTE DEL CONTE DI CAVOUR
- Il “delirio” come espressione socialmente compatibile
- I primi documenti letterari in volgare italiano
- Marcello Dudovich al tempo della committenza Aeronautica: 1920 – 1940
- Archeologia industriale a Guidonia Montecelio
- La Teoria della Dislocazione di Alexander: la dipendenza come un modo di adattarsi alla frammentazione sociale ed alla dislocazione individuale
- Centenario del Regno di Giordania, un secolo di indipendenza araba.
- S.A.R. Silvia Paternò di Spedalotto e Casa Savoia sempre in prima linea per i più bisognosi.
- Dal Latino alle prime testimonianze scritte in lingua italiana – parte terza
- Dal Latino alle prime testimonianze scritte in lingua italiana - Dal latino classico al latino medievale
- Dal Latino alle prime testimonianze scritte in lingua italiana – parte seconda
- Breve ricordo di Filippo di Edimburgo (1921-2021)
- 21 Aprile 2021
- Messaggio di SAR il Principe Amedeo, 25 aprile 2021
- La storia risorgimentale narrata con l’arte. Verso l’Unità d’Italia
- Il Trentino nella Grande Guerra con le parole di Maria Luisa Crosina
- Un fazzoletto azzurro per la Libertà e per il Re
- Recovery Fund, quale sarà la ripresa dalla pandemia?
- L'Ospedaletto e la Principessa di Castellaci
- Il “DNA verde” del Duca Amedeo di Savoia
- Elena, la Regina infermiera
- Dall’effetto Flynn alla punteggiatura
- Un piccolo omaggio a Casa d’Este, tra Cultura e Tradizione
- Duecento anni d'indipendenza greca
- Riscopriamo il nostro idioma: ad…
- Maria José del Belgio. L’ultima Regina d’Italia
- Ricordo del Re Umberto II di Savoia
- Lo storico viaggio del Papa in Iraq
- Riscopriamo il nostro idioma: ab…
- La Sicilia delle donne – Festival del genio femminile in Sicilia
- Messaggio di SAR il Principe Amedeo, 28 gennaio 2021
- Riscopriamo il nostro idioma: ab…
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 9
- Silvia Regina di Svezia
- Il Lambrusco, un vino amato in tutte le tavole del mondo
- Francobollo per il 150° anniversario dalla nascita di A.P. GIANNINI, il banchiere degli emigranti
- La gioventù senza radici. I Caduti e la Storia calpestati dall’indifferenza
- Covid in Svezia, il Re si assume la responsabilità: “Abbiamo fallito”
- Le sconosciute Monarchie del Delta del Niger
- Valorizzazione architettonica e urbanistica: il caso della Torre della Vittoria di Ferrara
- Blu Savoia, Blu d'Italia
- Honi soit qui mal y pense
- Sean Connery è morto. Il celebre attore inglese si è spento nel sonno, aveva novanta anni
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 8
- A scuola con Cuore
- NATÌA TUA TERRA
- La concessione di Tianjin. Un quartiere italiano nel cuore della Cina
- Relazione sul III° Convegno “Il lungo Regno di Vittorio Emanuele III”
- Il “testamento del capitano”, canto piemontese di oltre cinque secoli
- Ex Libris: piccole raffinatezze divenute arte
- Notte di luna piena
- La Penna che scrisse la storia
- Messaggio della Consulta dei Senatori del Regno, 10 ottobre 2020
- Messaggio di SAR la Principessa Maria Gabriella di Savoia, 10 ottobre 2020
- Messaggio di SAR il Principe Amedeo di Savoia, 10 ottobre 2020
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 7
- Il terremoto di Messina e Reggio Calabria - Due grandi città dilaniate e cancellate in 37 secondi
- Templi megalitici e misteriose tracce nella roccia di Malta e Gozo
- Quando le “Marescialle” profumavano il tabacco
- Letizia di Spagna “Non farà quello che vuole, farà quello che deve”
- La Monarchia vista da un repubblicano
- DOVERI DI UN CAPO DELLO STATO
- L'Acqua di Colonia: un giardino italiano racchiuso in un flacone
- Le partigiane dimenticate - Il ruolo delle donne della borghesia nella guerra di liberazione
- Sonja, Regina di Norvegia
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 6
- Il Gran Teatro la Fenice
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 3
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 2
- Napoli, Via Medina: la repressione di una legittima protesta
- Hong Kong e la sua Regina
- L’ignobile trattato
- Lettera di Federico S.
- La Regina di Cambogia e i Khmer Rossi
- Memorie di reduci: la ritirata di Russia
- I colori della nostra Bandiera
- Francesco Querini e quell’Italia coraggiosa e bella
- Follie Regali: quando la Regina Maria Antonietta scommise contro il nobile cognato
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 5
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 4
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella.1
- La Regina Monique di Cambogia
- Vittorio Emanuele II interprete e custode della Monarchia
- Morte della Principessa Badiya: un Regno d'Iraq da non dimenticare
- Di cioccolato caldo e favorite di Corte
- La Delizia Estense di Belriguardo, “la reggia dimenticata”.
- Giuseppe Scarabelli, un esempio di lungimiranza scientifica e di servizio alla sua città
- Máxima Zorreguieta, Regina consorte dei Paesi Bassi
- A.P. Giannini, orgoglio italiano
- Un Crocifisso contro il coronavirus: Il Cristo di Don Camillo chiamato a fermare la moderna peste.
- Associazionismo monarchico e Vincenzo Vaccarella
- La proprietà nel periodo liberale: Cavour, Giolitti, Einaudi
- Il Colpo di Zurigo, capolavoro di intelligence della Regia Marina
- Quando sulle guance delle Sabaude non fiorivano le rose di Versailles
- Gli 80 anni della Regina di Danimarca
- Un addio di amore
- La scrittura e il fascino della stilografica
- La vita al tempo del Coronavirus
- La Regina Elisabetta II e l'Italia
- Per Vittorio Emanuele II, Bicentenario della nascita del Re che ha fatto l'Italia
- Clodomiro Bonfigli e la riforma dei manicomi
- I miei incontri con Spadolini
- Ferrara e il suo carnevale rinascimentale tra giochi e battaglie
- L’Impero Ashanti, una Monarchia all’interno della Repubblica Ganese
- Lisbona 1960
- La Ricerca contro il cancro: una lotta indispensabile
- Brexit, tra le sfide del lungo Regno di Elisabetta II
- Chernobyl
- Atto di Fondazione

Incontro esclusivo con S.A.R. il Principe Aimone di Savoia alla Luiss
2025-10-05 13:05:00
2025-10-05 13:05:00
Patto per la Corona
Patto per la Corona //www.italianimonarchici.it/favicon.png

MEMORIA DI GIOVANNI GIOLITTI LO STATISTA DELLA NUOVA ITALIA
2025-07-17 15:21:00
2025-07-17 15:21:00
Patto per la Corona
Patto per la Corona //www.italianimonarchici.it/favicon.png

Trasposizioni inattendibili: il caso di Vittorio Emanuele III in M – Il figlio del secolo
2025-05-19 18:45:00
2025-05-19 18:45:00
Patto per la Corona
Patto per la Corona //www.italianimonarchici.it/favicon.png