di Gianluigi Chiaserotti Cadono i sessantaquattro anni della morte dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, avvenuta a Roma, il 23 luglio 1957. Ricordarlo è essenzialmente commentare ed analizzare il suo capolavoro “Il Gattopardo”. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Duca di Palma e Montechiaro, Principe di Lampedusa, nacque a Palermo il 23 dicembre 1896. Partecipò alla I Guerra Mondiale come ufficiale e rimase nell’esercito fino al 1925, laureandosi, nel frattempo, in Giurisprudenza all’Università di Torino. Il Tomasi si ritirò, quindi, a vita privata (anche perché avverso al Fascismo), viaggiando e dimorando per lunghi periodi all’estero. Il Tomasi divenne, quindi, saltuariamente critico di letteratura francese e di storia, negli anni 1926-27, su “Le Opere e i Giorni” (mensile culturale di Genova), ma le vicissitudini della vita interruppero codesto suo approccio professionale alle lettere. Rimase il conforto della lettura, il modo originale di smontare pezzo a pezzo, quasi come un giocattolo, gli scritti altrui. E soprattutto la ricerca, autore per autore, ed opera per opera, di una precisa collocazione biografica ed ambientale. Scrive il professor Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo del Lampedusa: Il Tomasi compose diversi saggi ed alcuni racconti, che, però, non diede mai alle stampe. Accadde che il Nostro accompagnò il cugino Lucio Piccolo di Calanovella, poeta scoperto da Eugenio Montale, ad un convegno letterario a San Pellegrino Terme (Bergamo) nel 1954. Ritornato a Palermo, il Lampedusa, affascinato, ma forse anche spronato dai forieri incontri avuti durante tale convegno, iniziò a scrivere il suo romanzo. Egli scrisse “Il Gattopardo” nel periodo che va’ dal 1955 al 1956, quindi, negli ultimi anni di vita, e praticamente tutti i giorni. E ciò indipendentemente dal successo, che la sorte in vita gli negò. Secondo la testimonianza della vedova dell’Autore, l’opera fu scritta “dal principio alla fine, tra il ’55 ed il ‘56” e ciò in pochissimi mesi. Ma il proposito di comporre e scrivere un romanzo storico, ambientato in Sicilia, all’epoca dello sbarco di Garibaldi a Marsala, ed imperniato sulla figura di un suo bisavo, era stato annunziato dal Nostro alla consorte almeno un venticinquennio prima. Ed “Il Gattopardo” ottenne un così vasto successo in Italia ed all’estero, da costituire uno dei singolari “casi letterari” degli ultimi decenni. Ma Giuseppe Tomasi di Lampedusa non lo poté vivere il successo, infatti, come si diceva all’inizio, morì a Roma il 23 luglio 1957. Vediamo brevemente la trama del romanzo. L’intreccio è più che noto! Sicilia 1860. Isola feudale e borbonica, turbata nei suoi torbidi sonni secolari dai «falò che le squadre dei ribelli accendevano ogni notte» stranamente simili a «quelle luci che si vedono ardere nelle camere degli ammalati gravi». E’ l’epoca del tramonto borbonico con l’instaurazione, anche nell’isola, della Monarchia sabauda. Il c. d. “mondo vecchio”, che, per i siciliani, vecchio non era, declina per fare spazio al c. d. “mondo nuovo”, emerso dalle idee illuministe, materialistiche e giacobine della Rivoluzione Francese. L’intera opera è incentrata ed intessuta intorno alla imponente figura ed alle abitudini del capo di un prestigioso casato isolano: don Fabrizio Corbèra, Principe di Salina [da ravvisarsi, come si diceva poc’anzi, in un bisavo dell’Autore, Giulio Tomasi di Lampedusa (1814-1885), se non, come alcuni esegeti affermano, nell’Autore medesimo, nobile generoso figlio della sua radiosa terra siciliana]. Don Fabrizio, lirico e critico nello stesso tempo, con occhio disincantato, fuori dagli avvenimenti, li vede mutare, li vede sfuggire dal di lui controllo e, suo malgrado, è del tutto incapace di adeguarvisi. «(…) è meglio il male certo che il bene non sperimentato (…)» scrive l’Autore, facendo suo, un proverbio millenario nel momento in cui il protagonista vota affermativamente per il plebiscito di annessione al Regno d’Italia, e ciò con stupore generale della gente di Donnafugata, restia a ratificare, sia per ragioni personali, sia che per fede religiosa, sia anche per aver ricevuto immensi favori dal passato regime. Ma anche perché questa gente effettuò un viaggio “ad limina Gattopardorum” in quanto stimava impossibile che un Principe di Salina, Pari del Regno delle Due Sicilie, potesse votare in favore di quella che la gente denominava Rivoluzione. Don Fabrizio, dall’alto del suo palazzo segue, altresì, con benevolenza, velata da un’amara ironia (ed allo stesso tempo si accorge che sta invecchiando: il suo “fluido vitale” non c’è più), la deliziosa storia d’amore tra suo nipote Tancredi Falconeri, combattente garibaldino, ed Angelica, figlia di don Calogero Sedara, Sindaco di Donnafugata, rappresentante della “nuova gente”. A tal proposito, particolare fu la reazione del Principe di Salina nel vedere salire le scale del suo palazzo di Donnafugata, il detto don Calogero in frac, e ciò nel corso del pranzo d’inizio della villeggiatura, nel quale il Principe era semplicemente vestito con un abito da pomeriggio. Scrive il Tomasi: «(…) Non rise invece il Principe al quale, è lecito dirlo, la notizia» (del frac di don Calogero) «fece un effetto maggiore del bollettino dello sbarco a Marsala». Praticamente don Fabrizio, massimo proprietario del feudo, si sentiva più come tale, ma fu costretto, dagli eventi della Rivoluzione, a ricevere, vestito da pomeriggio, un invitato in abito da sera. Tutto codesto evolversi di fatti e situazioni, ben descritte e particolareggiate dal Tomasi, ha il suo epilogo nel ballo ove il protagonista, consumando un valzer con Angelica, si accorge più che mai del suo tramonto, di essere corroso da un tragico senso della morte e praticamente esce di scena. Tutta l’opera fu scritta di getto, ma la dovizia di particolari a cui l’Autore si è dedicato con paziente attenzione è segno che egli sentiva quel “mondo” più che suo. La figura del gesuita padre Pirrone, cappellano della Casa, il cane Benedicò, gli oggetti dell’arredamento, le figlie del Principe, la tiepida e religiosa moglie, i periodi di villeggiatura (da agosto a novembre) in campagna ed a caccia in Donnafugata, con l’organista della chiesa, don Ciccio Tumeo. Opera meditata a lungo, dunque, se pur scritta, anzi manoscritta, di getto, come si diceva poc’anzi. E’ più che lecito ritenere che la morte del Tomasi abbia impedito del tutto quel lavoro di revisione e di limatura che sarebbe valso a “Il Gattopardo” un carattere di maggior compiutezza. Il romanzo apparve nell’autunno 1958 [dopo il rifiuto di Elio Vittorini per la Mondadori], a cura dello scrittore bolognese, ma ferrarese di adozione (città di antiche e feconde tradizioni, attraverso i secoli, di letterati, di poeti, di artisti, di politici, di giornalisti) Giorgio Bassani – al quale pervenne, a sua volta, da Elena Croce - e la compiutezza, nonché correttezza dell’edizione non venne messa in discussione fino al 1968, quando si riscontrarono centinaia di divergenze, anche cospicue, fra il manoscritto ed il testo stampato. La questione era già stata sollevata da Francesco Orlando, docente di teoria e tecnica del romanzo alla Scuola Normale di Pisa, nel suo “Ricordo di Lampedusa” (1962) (pag. 82). Infatti, come commenta quest’ultimo, tre sono le stesure dell’opera, e precisamente: una prima stesura manoscritta e raccolta in più quaderni (1955-1956); una seconda stesura dattiloscritta da Orlando e corretta dall’Autore (1956), ed, infine, una ricopiatura autografa in otto parti del 1957, recante sul frontespizio: “Il Gattopardo (completo)”. Si è adottato la dizione “parti”, anziché capitoli, perché così volle il Tomasi nell’indice analitico. Infatti ogni sezione dell’opera è propriamente una parte, «cioè la trattazione da una angolazione diversa, ed in se stessa compiuta, della condizione siciliana», come limpidamente scrive Gioacchino Lanza Tomasi nella premessa dell’edizione dell’opera del 1969. Infatti le otto parti in cui è composto il romanzo potrebbero tranquillamente essere a se stanti in quanto è come se ognuna iniziasse e terminasse l’illustrazione di un quadro. Lo straordinario interesse del romanzo non sta tanto nella trama, che poi, come abbiamo visto, è la biografia del Principe di Salina, quanto piuttosto nel ricco e sottile gioco della complicata realtà interiore del protagonista, che nella finissima arte del Tomasi trova una limpida rappresentazione. Don Fabrizio - singolare temperamento, nel quale l’orgoglio e l’intellettualismo ereditati dalla madre, nobile tedesca, si scontrano in perpetuo con la sensualità e la fiacchezza ricevute in eredità dal padre – assiste inerte alla rovina del proprio ceto ed al sorgere, come si è detto poc’anzi, di una nuova classe sociale. Il motivo della “nobiltà in sfacelo” non viene intonato a patetico rimpianto per un mondo che scompare, che viene meno, che si sfalda, così ben svolto in lirica contemplazione dell’inarrestabile fluire, perire e mutare delle cose: quel vedere andar tutto “alla deriva nei meandri” come scrive il Lampedusa “del lento fiume pragmatistico siciliano”. Peraltro la vena alquanto lirica del Tomasi trova un sapiente contrappunto in una costante venatura umoristica, la quale si ramifica per tutta l’opera, quasi elemento equilibratore ed argine all’arido ed invadente scetticismo del protagonista. Scetticismo che, quando inaridisca e non bruci entro di sé la consistenza fantastica della pagina, trova, in quel sorriso, una giustificazione ed un suo pungente limite. Nel bisavo Giulio Tomasi di Lampedusa, alias don Fabrizio Corbèra, sembra quasi che ritroviamo il medesimo Autore, uomo aperto ai problemi ed alle complicazioni spirituali del nostro tempo, il quale nella sua realtà (cioè alla conclusione di un ciclo storico, che è la Seconda Guerra Mondiale) crede di veder confermata la tesi del fallimento, sul piano sociale e politico del Risorgimento Italiano, che, con particolare arguzia definì «una rumorosa, romantica commedia con qualche macchiolina di sangue sulla veste buffonesca» soprattutto riguardo al sempre attuale problema del Sud d’Italia. Fallimento, d’altronde, insito nel destino d’una regione e d’una gente antichissima e di antiche tradizioni. La continuità/immedesimazione Corbèra/Tomasi, la quale, nei momenti migliori, si risolve in un gioco di psicologici scambi e di magiche dissolvenze, direi quasi, entro cui passato e futuro vengono liricamente annullati, si infrange nel momento in cui il Tomasi di Lampedusa balza bruscamente, quasi come un anacoluto, in primo piano con polemiche digressioni. E ciò è un altro recondito aspetto de “Il Gattopardo” che ha contribuito a farlo qualificare “saggistico”. Come quando l’Autore esprime il suo amaro giudizio sulle conseguenze di quella “nottata di vento lercio”, cioè la nottata dei risultati dell’addomesticato plebiscito, nel corso della quale nel borgo di Donnafugata era nata l’Italia, ma era stata uccisa la “buonafede” dei Siciliani, ad opera di quello «stupido annullamento della prima espressione di libertà che a questi si fosse mai presentata». Al momento storico (la piccola storia fatta di piccoli uomini) si avvicenda il più vasto motivo del fermo, eterno ed “indifferente” fluire del mitico tempo siciliano. Nell’“ambiente”, nel “clima”, nel medesimo “sole siciliano”, si direbbe che quella indifferenza trovi una mostruosa e drammatica ipostasi, nel senso della Trinità: «apparve l’aspetto della vera Sicilia (…) un’aridità ondulante all’infinito (…)»; «ondulazioni di un solo colore, deserte come disperazione», «Il sole narcotizzante (…) annullava le volontà singole e manteneva ogni cosa in una immobilità servile cullata in sogni violenti, in violenze che partecipavano dell’arbitrarietà dei sogni». Codesta è una tensione costante, che trova il suo centro propulsore nella natura del protagonista, e cioè a riportare ad una sua visione interna i dati concretissimi della realtà esterna, la quale assume i riverberi e le tonalità della sostanza spirituale di don Fabrizio. E’ più spesso la realtà sensibile ad aprirsi, con le sue violente suggestioni, dei varchi fin dentro le “zone non coscienti” del protagonista, con il suggerire certe lugubri fantasie che lasciano in fondo al suo animo “un sentimento di lutto”. Ecco quindi il pessimismo dell’Autore, con il tema della morte che è uno dei più fecondi delle sue ispirazioni. La coerenza fantastica del romanzo va ricercata appunto nel motivo lirico della morte, o meglio, del desolato motivo d’origine esistenziale dell’“essere per la morte”. E qui desidero precisare che la lirica conclusione del romanzo non si ravvisa tanto nella “parte”, la settima, della morte di don Fabrizio (nel 1883, invece il bisavo del Tomasi morì nel 1885) - con quell’incontro con la donna simbolo della fredda realtà stellare e con quell’assunzione in una patria iperurania del “puro calcolo” che sembrano un’astratta e metafisica soluzione, poeticamente sterile ed arbitraria – ma bensì nella “parte ottava” che rappresenta un desolato prolungamento (fino al 1910) della terrena esistenza del Principe di Salina, il cui fluido vitale va lentamente e stancamente esaurendosi nelle tre figlie superstiti, finchè tutto trova pace «in un mucchietto di polvere livida». E’ proprio qui che poeticamente si risolve il sentimento di quella “compiaciuta attesa del nulla” che domina tutto il libro. Analizziamo, per sommi capi, la figura di don Fabrizio. Scrive il Tomasi di Lampedusa, don Fabrizio era “immenso e fortissimo”. Egli è per parte di madre erede di un’antica dinastia tedesca. La carnagione lattea ed i capelli biondo miele, segno evidente di questa discendenza, non ne rappresentano però l’aspetto più profondo, che invece riguarda il temperamento. Autoritario ed incorruttibile, orgoglioso difensore delle tradizioni e del proprio casato ma anche aperto alla scienza e singolarmente incline alle matematiche, apprezzato astronomo ed addirittura scopritore di due piccoli pianeti (il bisavo dell’Autore era un astronomo). Il Principe deve conciliare la sua anima germanica con la sensualità superficiale ed impulsiva, la facile irritabilità ed il disfattismo fatalista che gli vengono dal padre. Don Fabrizio è ironico e pessimista “in perpetuo scontento”, osserva, come abbiamo accennato, con inquietudine ed indolenza la rovina che sta per travolgere i privilegi della sua classe e la consistenza del suo patrimonio. Egli si considera l’ultimo Gattopardo. L’ultima personificazione dell’araldico animale che campeggia nell’azzurro stemma della sua famiglia. Dopo di lui banali logiche di mercato stravolgeranno il senso medesimo dell’aristocrazia trasformandola in un vuoto decoro, utile forse ad agevolare carriere borghesi. Il rifiuto che il Principe oppone al nobile piemontese Aimone Chevalley di Monterzuolo, giunto da Torino con l’incarico di offrirgli il laticlavio di Senatore del Regno d’Italia, non è un gesto di orgoglio, ma la disperata fedeltà alle proprie radici, alle proprie tradizioni, al carattere dei siciliani, alla propria, ormai disillusa, “decenza” morale, perché, dice il Principe: «(…) i Siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti: (…) ogni intromissione di estranei sia per origine sia anche, se si tratti di Siciliani, per indipendenza di spirito, sconvolge il loro vaneggiare di raggiunta compiutezza». Dice padre Pirrone al Principe: «Senatores boni viri, senatus autem mala bestia». La grandezza, ma anche l’originalità del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sta nel fatto della immensa cultura dell’Autore. Infatti il suo leggere, il suo documentarsi quasi quotidianamente lo spinsero a rivedere gli sciapi, ma veri diari dell’avo Giuseppe (1838-1908), il quale amava annotare la giornata incorniciata da rosari (il romanzo inizia con la quotidiana recita del Santo Rosario) e pratiche di devozione. E qui nasce il naturale raffronto fra “Il Gattopardo” e “Le confessioni di un italiano” di Ippolito Nievo, che descrivono effettivamente una civiltà al tramonto. Ma il Lampedusa, come scrive il Lanza Tomasi: In Ippolito Nievo ed in Giuseppe Tomasi di Lampedusa i loro racconti, entrambi altamente biografici, si rifanno alle impressioni ed alle annotazioni dei loro avi. Altro raffronto con il romanzo storico lo possiamo comodamente e tranquillamente trovare ne “I Viceré” di Federico de Roberto, romanzo anch’esso che narra il trapasso dal Regno delle Due Sicilie a quello d’Italia, ponendo in risalto i problemi politici e sociali della Sicilia, raccontando le vicende di una famiglia dell’alta aristocrazia siciliana di origine spagnola (anche don Fabrizio lo era) gli Uzeda, i cui componenti, con il mutare delle generazioni e delle circostanze, continuano a distinguersi per alcune sinistre caratteristiche, come l’egoismo, la prepotenza e l’avidità. Ma tutto ciò non c’è ne “Il Gattopardo”, ove don Fabrizio è tutt’altro che egoista, prepotente ed avido. Forse un larvato egoismo, ma misto all’invidia, lo troviamo in Concetta, la figlia maggiore di don Fabrizio, innamorata da sempre del cugino Tancredi, la quale non accetterà mai l’unione di quest’ultimo con Angelica. La vicenda descritta ne “Il Gattopardo” puo’, a prima vista, far pensare che si tratti di un romanzo storico. Il Tomasi ha sicuramente tenuto presente, come abbiamo poc’anzi visto, una tradizione narrativa siciliana (la novella “Libertà” di Giovanni Verga, “I Viceré” del de Roberto e la novella “I vecchi e i giovani” di Luigi Pirandello, ispirata al fallimento risorgimentale, drammaticamente avvertito in Sicilia, dove erano vive le speranze di un profondo rinnovamento). Ma mentre de Roberto è, senza dubbio, per codesta tematica il più significativo, indaga le motivazioni del fallimento con una complessa rappresentazione delle opposte forze in gioco, il Lampedusa presenta la vicenda risorgimentale attraverso il machiavellismo della classe dirigente, che “in extremis” si mette al servizio dei garibaldini e dei piemontesi, convinta che fosse il modo migliore perché tutto restasse com’era. Questa rappresentazione è naturalmente ristretta, per la prospettiva da cui è descritta. Restano fuori dal romanzo molti eventi importanti (per esempio la rivolta dei contadini di Bronte del 2 agosto 1860, stroncata da Nino Bixio e descritta dal Verga). Da questo punto di vista quindi le mancanze de “Il Gattopardo” quale romanzo storico del Risorgimento in Sicilia sono evidenti. Scrive il giornalista ed uomo politico Mario Alicata: E quindi l’originalità del valore de “Il Gattopardo” va ricercata dunque al di fuori della prospettiva del romanzo storico. Nell’avviarmi alla conclusione, mi sia concesso di citare alcuni tratti del romanzo. L’arrivo del Principe e della sua famiglia a Donnafugata era considerata una festa per l’antico borgo. Ed è bellissimo quello che scrive il Tomasi al riguardo: «(…) perché i villici di Donnafugata non avevano nulla contro il loro tollerante signore, che così spesso dimenticava di esigere i canoni e i piccoli fitti; e poi, avvezzi a vedere il Gattopardo baffuto danzare sulla facciata del palazzo, sul frontone delle chiese, in cima alle fontane, sulle piastrelle maiolicate delle case, erano curiosi di vedere adesso l’autentico Gattopardo in pantaloni di piqué distribuire a tutti zampate amichevoli e sorridere nel volto di felino cortese. “Non c’è da dire tutto è come prima, meglio di prima anzi”». Il non riuscire ad adeguarsi alla nuova situazione da parte di don Fabrizio è limpidamente dipinto dal Tomasi nel seguente passo: «(…) le mille astuzie alle quali doveva piegarsi lui, il Gattopardo, che per tanti anni aveva spazzato via le difficoltà con un rovescio della zampa». Ed infine, la splendida, ma amara conclusione della “parte settima”, cioè la morte del Principe di Salina: «(…) [la morte] era lei, la creatura bramata da sempre che veniva a prenderlo: strano che così giovane com’era si fosse arresa a lui; l’ora della partenza del treno doveva essere vicina. Giunta faccia a faccia con lui sollevò il velo e così, pudica ma pronta ad esser posseduta, gli apparve più bella di come mai l’avesse intravista negli spazi stellari. Il fragore del mare si placò del tutto». Ed il romanzo è tutto qui. I pensieri del Principe di Salina oscillano nel corso dell’opera tra “έρως” e “θάνατος”, amore e morte. Una curiosità. L’ultima “parte”, l’“ottava”, ambientata a Villa Salina nel maggio 1910, esattamente mezzo secolo dopo, la “prima parte”, con protagoniste le tre figlie sopravvissute al Principe, rimaste nubili. Fatto centrale di tale parte è la visita alla villa del Cardinale di Palermo, del quale il Tomasi scrive «(…) era davvero un sant’uomo;». Nell’affermare ciò, l’Autore si è sicuramente ispirato al suo antenato, Giuseppe Maria Tomasi (1649-1713), sacerdote dell’Ordine dei Teatini, Cardinale di Santa Romana Chiesa, beatificato nel 1803, canonizzato da San Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla, 1920-2005) il 12 ottobre 1986 e sepolto nella Chiesa romana di Sant’Andrea della Valle. Il Lampedusa nell’affermare la santità del Cardinale, auspicava sicuramente la canonizzazione del suo antenato. Tra le numerosissime recensioni al romanzo, è molto interessante quella del padre gesuita Giuseppe de Rosa sulla rivista dell’Ordine “Civiltà Cattolica” dell’aprile 1959. E’ una recensione molto ampia [ben quattordici (14) pagine] che tocca, oltre a quello morale e religioso, molti altri aspetti dell’opera. E’ un libro “bellissimo” ma che merita di «richiamare l’attenzione per i problemi umani che offre alla nostra meditazione». Quindi il de Rosa analizzando la semplicità della trama, sviluppa il suo discorso critico partendo da una distinzione già effettuata dagli altri numerosi recensori, tra lo sfondo storico (“il tema che potremmo chiamare sociale”) e le meditazioni del protagonista (“il tema della morte”). Anche se entrambi in tutto questo don Fabrizio è “il portavoce dell’autore”. Non sappiamo nulla dei sentimenti intimi religiosi del Tomasi: «ma il Gattopardo non lo rivela un credente», ma «visibilmente un figlio della sua epoca, incredula e liberaleggiante in fatto di religione». Infine, scrive Giorgio Bassani, nell’introduzione del romanzo del 1958: Il romanzo ebbe anche la sua fortuna con il regista Luchino Visconti (1906-1976), il quale, nel 1963, ne trasse un vero ed autentico capolavoro di arte cinematografica. Da poco la Feltrinelli ha dato alle stampe una nuova edizione del romanzo, sempre a cura di Gioacchino Lanza Tomasi, con una più ampia introduzione, una parte inedita e delle poesie attribuite a Don Fabrizio ed a Padre Pirrone. Filo conduttore dell’opera, come abbiamo visto, è la massima di Tancredi «(…) se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». E’, quindi, una spietata analisi del Risorgimento, accettato dall’aristocrazia siciliana nel senso di detta massima. Ed infatti come si fa a sradicare un popolo ed una terra da antiche tradizioni ed usi con superficiali avvenimenti imposti in un momento di generale turbamento? Se si vuole veramente cambiare, si deve procedere con attenzione e cautela, ed allora si avrà l’adeguamento necessario. Quindi solo chi conosce bene queste tradizioni ed usi puo’, restando dove il destino lo ha giustamente collocato, cambiare ed adeguare certi valori alla realtà (ogni riferimento alla odierna situazione italiana e del tutto “puramente casuale”). Tutto questo ne “Il Gattopardo”, attualissimo sempre per chi voglia leggerlo o chi desideri leggerlo nuovamente, è dipinto in maniera magistrale e nulla viene meno all’intreccio ed al romanzo tanto cari a tutta la narrativa europea del secolo XIX. Le immagini offerte della Sicilia narrata sono vive, animate da uno spirito alacre e modernissimo, anche se ampiamente consapevole della problematica storica, politica e letteraria contemporanea; tutto ciò risente dei canoni e dei modelli del romanzo moderno da Proust in poi. Se si richiede di tornare alle vere tradizioni, quindi, non è per nostalgismo, ma per “cambiare” si deve provare codesta immane forza del passato per un futuro più costruttivo e migliore. Se ciascuno di noi potesse sentimentalmente ciò, tutto sarebbe molto bello e la lezione de “Il Gattopardo” sarebbe ben compresa e sempre animata da uno spirito costruttivo e degno della nostra nobile indole. Ecco la vitalità e la vivacità, come si diceva prima, dell’opera che, ad oltre mezzo secolo dalla sua pubblicazione, è sempre molto educativa (forse questo voleva Giuseppe Tomasi di Lampedusa) per le nuove generazioni che tendono a costruire un futuro senza conoscere le tradizioni, la saggezza e la moralità di chi fu prima di noi.


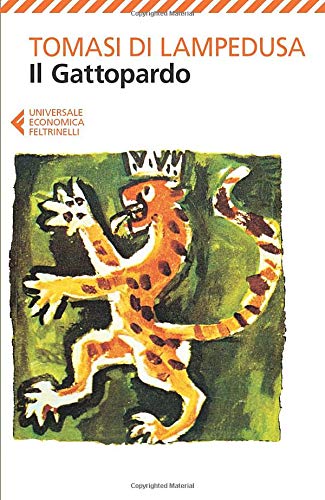

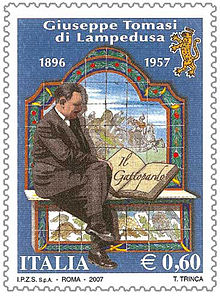
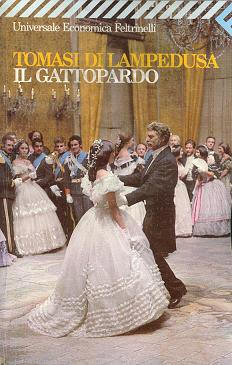

Presidente Michele D'Ambrosio; Segretario Nazionale Pietro Fontana
Web Design Gennaro Capasso
© Italiani Monarchici - Patto per la Corona, 2019
%20-%20copia%20-%20copia.png)
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957)
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957)
28/07/2021 18:50
28/07/2021 18:50
Patto per la Corona
Patto per la Corona //www.italianimonarchici.it/favicon.png
Oggi, gianluigichiaserotti,

di Gianluigi Chiaserotti
- Incontro esclusivo con S.A.R. il Principe Aimone di Savoia alla Luiss
- Comunicato stampa della Casa Reale di Savoia - 26/09/2025
- Comunicato ufficiale dalla Consulta dei Senatori del Regno - 29 agosto 2025
- Cixi, una reggente autoritaria
- MEMORIA DI GIOVANNI GIOLITTI LO STATISTA DELLA NUOVA ITALIA
- Trasposizioni inattendibili: il caso di Vittorio Emanuele III in M – Il figlio del secolo
- Kang Youwei
- Partecipazione alla messa di inizio pontificato di Leone XIV
- Partecipazione alle solenni esequie in Vaticano
- Messaggio del Principe Aimone di Savoia nella triste circostanza della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco
- Messaggio di S.A.R. il Principe Aimone | Pasqua 2025
- Intervista rilasciata al “Corriere della Sera” da S.A.R. il Principe Aimone di Savoia, Capo della Real Casa di Savoia (24 marzo 2025)
- La Commemorazione pronunciata dal Senatore Gianni Ruzzier nel Giorno del Ricordo (Rimini, 10 gennaio 2025)
- Giovanni Verga e “I Malavoglia” nel suo tempo, si può parlare di ecologismo letterario? (Parte quarta)
- Messaggio di S.A.R. il Principe Aimone | Natale 2024
- Giovanni Verga e “I Malavoglia” nel suo tempo, si può parlare di ecologismo letterario? (Parte terza)
- Casa Savoia e lo scoutismo
- I Rifugi Sabaudi in Italia
- Giovanni Verga e “I Malavoglia” nel suo tempo, si può parlare di ecologismo letterario? (Parte seconda))
- Giovanni Verga e “I Malavoglia” nel suo tempo, si può parlare di ecologismo letterario? (Parte prima)
- Scomparsa del Principe Michele di Grecia
- Addio al Principe Michele di Grecia
- Terzo anniversario della morte di S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia Duca di Savoia già Duca d'Aosta
- I resti di Ferdinando I arrivano in Bulgaria
- Il Breve Regno di Amedeo I di Spagna: Una Monarchia Effimera
- In memoria di S.A.R. la Principessa Maria Cristina di Savoia Aosta di Borbone delle Due Sicilie
- Messaggio di S.A.R. il Principe Aimone | Pasqua 2024
- FRANCIA E RIVOLUZIONE
- I riti nei funerali reali
- Giacomo Puccini e Casa Savoia: un legame profondo
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (Conclusioni)
- La Danimarca ha un Nuovo Re: SUA MAESTÀ FREDERIK X RE DI DANIMARCA
- Comunicato "Patto per la Corona" sulla morte di Vittorio Emanuele di Savoia
- L’ OSPEDALE DI MAJANO
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (parte seconda c)
- La Resistenza dei Monarchici contro il Regime Fascista
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (parte seconda b), IL DELITTO MATTEOTTI
- In memoria di Norma Cossetto
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (parte seconda a) Comparazione della stampa durante il Governo fascista in concomitanza dell’omicidio Matteotti (19
- I francobolli del Regno d’Italia con Vittorio Emanuele II
- DALLA STAMPA LIBERALE ALLA STAMPA DI REGIME (parte prima) Comparazione della stampa durante il Governo fascista in concomitanza dell’omicidio Matteotti (1925) e
- Vitale Cao di San Marco e i gioielli dei Savoia
- Torta Tenerina
- I Savoiardi
- Monterotondo e il 9 settembre 1943
- L'abito tra noi e gli altri
- Torta Savoia
- La monarchia, l'Italia e gli italiani
- DUE RAMI DELLO STESSO ALBERO
- Il Fondo Cencetti e la Dalmazia
- La Pizza Margherita
- La "Pietra del Destino" all'Incoronazione di Re Carlo III
- Nascita della Regia Aeronautica Italiana e i suoi 100 anni
- Centenario dell’Aeronautica Militare
- I 100 anni dell’Aeronautica militare e l’“Air Force Experience”
- La successione dinastica in Casa Savoia
- Ode al 18 marzo
- A Re Umberto II
- IL RUOLO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA NELLA GRANDE GUERRA – PARTE 2
- Nascita del francobollo
- Qualche riflessione sui mutamenti architettonici nel Sud Italia
- IL RUOLO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA NELLA GRANDE GUERRA
- Il Duomo di Gemona del Friuli
- L’Indipendenza degli Stati Uniti d’America dal colonialismo inglese
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 6
- La vita torinese del Principe di Piemonte
- Conferenza del 29 ottobre 2022
- Fondazione Villa Piccolo di Calanovella
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 5
- Conoscere l’Anpi
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 4
- Dante e il Monarchia
- Nascita e formazione del Principe Umberto
- August von Mackensen: l’uomo delle “cinque Germanie”
- Le visite ufficiali (e non) di Umberto II a Varese
- A tavola con gli antichi romani
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 3
- Messaggio di SAR il Principe Aimone al Liceo Amedeo di Savoia di Pistoia
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia 2
- Il ridisegno della città: le trasformazioni della struttura urbana dopo l’Unità d’Italia
- Un ricordo di un grande: Totò
- La kalokagathia
- Il corvo
- LA FAMIGLIA REALE DI SAVOIA – Parte prima (Vittorio Emanuele II ed Umberto I)
- L' Arco di Costantino
- AMEDEO DI SAVOIA OTTANTA ANNI DOPO (1942-2022)
- Il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II (1952-2022)
- Palazzo Aeronautica 1931-2021
- Progetto a medio-lungo termine: eliminazione dell'uso dei contanti
- Rudolf Hess presso la corte del duca di Hamilton
- Il 50° discorso alla Nazione della Regina Margrethe II di Danimarca nel segno della continuità
- Saracinesco - Un Paese di discendenza araba nella Valle dell’Aniene
- La linea dei Savoia Duchi di Genova (1831-1996)
- Puccini ricordato nel giorno della sua nascita
- LUDWIG VAN BEETHOVEN: IL TITANO DELLA MUSICA (1770-1827)
- Recensione del libro “Cifra reale”
- Italiani Monarchici – Patto per la Corona: un bilancio 2021 nel segno della crescita.
- Simeone II di Bulgaria: da Zar a Primo ministro
- Storia e ruolo del Cattolicesimo nella caduta del Regime comunista in Ungheria, parte 2 Caduta del Regno e terrore
- Il centenario del Milite Ignoto
- In principio era solo D’Annunzio. Contro uno e contro tutti. L’alba prima del tramonto
- Scomparso il partigiano Claudio Perra, Carabiniere reale che assistette all'arresto di Mussolini
- Il profondo legame tra Milite Ignoto e Corona
- Cibo da Re
- Gioacchino Volpe (1876-1971)
- Appello associativo sul Centenario del Milite Ignoto
- Relazione sulla serie di eventi del 16 e 17 ottobre 2021 a Roma in celebrazione del genetliaco di SAR il Principe Aimone, Duca di Savoia, e in memoria dell’Augu
- Messaggio di SAR il Principe Aimone, 16 ottobre 2021
- Storia e ruolo del Cattolicesimo nella caduta del Regime comunista in Ungheria
- Dante Alighieri: 700 anni dopo
- Ciciliano e il castello Theodoli - un borgo cresciuto intorno alla fortezza
- La Reggia di Colorno ...e i Savoia
- Intervista a SAR la Principessa Soraya Malek per un Afghanistan finalmente libero
- Papa Francesco e la stretta sul rito antico. La questione liturgica alimenta il dibattito nella comunità cattolica.
- La grande musica riapre il sipario sull’Italia - L’Aida diretta da Riccardo Muti all’Arena di Verona
- Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957)
- Francesco V d’Austria-Este
- L'Arma dei Bersaglieri festeggia il suo 185mo anniversario
- 1861-2021 IL CENTOSESSANTESIMO DELLA MORTE DEL CONTE DI CAVOUR
- Il “delirio” come espressione socialmente compatibile
- I primi documenti letterari in volgare italiano
- Marcello Dudovich al tempo della committenza Aeronautica: 1920 – 1940
- Archeologia industriale a Guidonia Montecelio
- La Teoria della Dislocazione di Alexander: la dipendenza come un modo di adattarsi alla frammentazione sociale ed alla dislocazione individuale
- Centenario del Regno di Giordania, un secolo di indipendenza araba.
- S.A.R. Silvia Paternò di Spedalotto e Casa Savoia sempre in prima linea per i più bisognosi.
- Dal Latino alle prime testimonianze scritte in lingua italiana – parte terza
- Dal Latino alle prime testimonianze scritte in lingua italiana - Dal latino classico al latino medievale
- Dal Latino alle prime testimonianze scritte in lingua italiana – parte seconda
- Breve ricordo di Filippo di Edimburgo (1921-2021)
- 21 Aprile 2021
- Messaggio di SAR il Principe Amedeo, 25 aprile 2021
- La storia risorgimentale narrata con l’arte. Verso l’Unità d’Italia
- Il Trentino nella Grande Guerra con le parole di Maria Luisa Crosina
- Un fazzoletto azzurro per la Libertà e per il Re
- Recovery Fund, quale sarà la ripresa dalla pandemia?
- L'Ospedaletto e la Principessa di Castellaci
- Il “DNA verde” del Duca Amedeo di Savoia
- Elena, la Regina infermiera
- Dall’effetto Flynn alla punteggiatura
- Un piccolo omaggio a Casa d’Este, tra Cultura e Tradizione
- Duecento anni d'indipendenza greca
- Riscopriamo il nostro idioma: ad…
- Maria José del Belgio. L’ultima Regina d’Italia
- Ricordo del Re Umberto II di Savoia
- Lo storico viaggio del Papa in Iraq
- Riscopriamo il nostro idioma: ab…
- La Sicilia delle donne – Festival del genio femminile in Sicilia
- Messaggio di SAR il Principe Amedeo, 28 gennaio 2021
- Riscopriamo il nostro idioma: ab…
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 9
- Silvia Regina di Svezia
- Il Lambrusco, un vino amato in tutte le tavole del mondo
- Francobollo per il 150° anniversario dalla nascita di A.P. GIANNINI, il banchiere degli emigranti
- La gioventù senza radici. I Caduti e la Storia calpestati dall’indifferenza
- Covid in Svezia, il Re si assume la responsabilità: “Abbiamo fallito”
- Le sconosciute Monarchie del Delta del Niger
- Valorizzazione architettonica e urbanistica: il caso della Torre della Vittoria di Ferrara
- Blu Savoia, Blu d'Italia
- Honi soit qui mal y pense
- Sean Connery è morto. Il celebre attore inglese si è spento nel sonno, aveva novanta anni
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 8
- A scuola con Cuore
- NATÌA TUA TERRA
- La concessione di Tianjin. Un quartiere italiano nel cuore della Cina
- Relazione sul III° Convegno “Il lungo Regno di Vittorio Emanuele III”
- Il “testamento del capitano”, canto piemontese di oltre cinque secoli
- Ex Libris: piccole raffinatezze divenute arte
- Notte di luna piena
- La Penna che scrisse la storia
- Messaggio della Consulta dei Senatori del Regno, 10 ottobre 2020
- Messaggio di SAR la Principessa Maria Gabriella di Savoia, 10 ottobre 2020
- Messaggio di SAR il Principe Amedeo di Savoia, 10 ottobre 2020
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 7
- Il terremoto di Messina e Reggio Calabria - Due grandi città dilaniate e cancellate in 37 secondi
- Templi megalitici e misteriose tracce nella roccia di Malta e Gozo
- Quando le “Marescialle” profumavano il tabacco
- Letizia di Spagna “Non farà quello che vuole, farà quello che deve”
- La Monarchia vista da un repubblicano
- DOVERI DI UN CAPO DELLO STATO
- L'Acqua di Colonia: un giardino italiano racchiuso in un flacone
- Le partigiane dimenticate - Il ruolo delle donne della borghesia nella guerra di liberazione
- Sonja, Regina di Norvegia
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 6
- Il Gran Teatro la Fenice
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 3
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 2
- Napoli, Via Medina: la repressione di una legittima protesta
- Hong Kong e la sua Regina
- L’ignobile trattato
- Lettera di Federico S.
- La Regina di Cambogia e i Khmer Rossi
- Memorie di reduci: la ritirata di Russia
- I colori della nostra Bandiera
- Francesco Querini e quell’Italia coraggiosa e bella
- Follie Regali: quando la Regina Maria Antonietta scommise contro il nobile cognato
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 5
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella. 4
- La storia dell'associazionismo e partitismo monarchico italiano attraverso Vincenzo Vaccarella.1
- La Regina Monique di Cambogia
- Vittorio Emanuele II interprete e custode della Monarchia
- Morte della Principessa Badiya: un Regno d'Iraq da non dimenticare
- Di cioccolato caldo e favorite di Corte
- La Delizia Estense di Belriguardo, “la reggia dimenticata”.
- Giuseppe Scarabelli, un esempio di lungimiranza scientifica e di servizio alla sua città
- Máxima Zorreguieta, Regina consorte dei Paesi Bassi
- A.P. Giannini, orgoglio italiano
- Un Crocifisso contro il coronavirus: Il Cristo di Don Camillo chiamato a fermare la moderna peste.
- Associazionismo monarchico e Vincenzo Vaccarella
- La proprietà nel periodo liberale: Cavour, Giolitti, Einaudi
- Il Colpo di Zurigo, capolavoro di intelligence della Regia Marina
- Quando sulle guance delle Sabaude non fiorivano le rose di Versailles
- Gli 80 anni della Regina di Danimarca
- Un addio di amore
- La scrittura e il fascino della stilografica
- La vita al tempo del Coronavirus
- La Regina Elisabetta II e l'Italia
- Per Vittorio Emanuele II, Bicentenario della nascita del Re che ha fatto l'Italia
- Clodomiro Bonfigli e la riforma dei manicomi
- I miei incontri con Spadolini
- Ferrara e il suo carnevale rinascimentale tra giochi e battaglie
- L’Impero Ashanti, una Monarchia all’interno della Repubblica Ganese
- Lisbona 1960
- La Ricerca contro il cancro: una lotta indispensabile
- Brexit, tra le sfide del lungo Regno di Elisabetta II
- Chernobyl
- Atto di Fondazione

Incontro esclusivo con S.A.R. il Principe Aimone di Savoia alla Luiss
2025-10-05 13:05:00
2025-10-05 13:05:00
Patto per la Corona
Patto per la Corona //www.italianimonarchici.it/favicon.png

MEMORIA DI GIOVANNI GIOLITTI LO STATISTA DELLA NUOVA ITALIA
2025-07-17 15:21:00
2025-07-17 15:21:00
Patto per la Corona
Patto per la Corona //www.italianimonarchici.it/favicon.png

Trasposizioni inattendibili: il caso di Vittorio Emanuele III in M – Il figlio del secolo
2025-05-19 18:45:00
2025-05-19 18:45:00
Patto per la Corona
Patto per la Corona //www.italianimonarchici.it/favicon.png